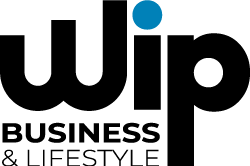Potreste essere all’oscuro di termini che si richiamano a filoni del pensiero economico e questo non vi facilita la lettura di articoli interessanti, o l’ascolto di trasmissioni televisive importanti o ancora l’intervenire in discussioni stimolanti. Si può rimediare con questa breve storia del pensiero economico dagli antichi ai giorni nostri.
Nell’antica classe dirigente greca c’erano anche i filosofi, alcuni dei quali hanno scritto di economia. Molto spesso in disaccordo tra loro. Tra questi, si annoverano Platone (428-348 a.C.) e Aristotele (384322 a.C.). Aristotele, che è stato il primo a coniare il termine “economico” (oikonomiké), sosteneva nel libro primo della “Politica” che la proprietà doveva essere privata perché quando era gestita dalla comunità, nessuno si assumeva la responsabilità di conservarla e migliorarla. Non solo: la proprietà privata, a suo parere, incentivava il lavoro che portava ricchezza e benessere. Nello stato ideale di Platone, ben descritto in «Repubblica», invece, la proprietà privata doveva essere abolita perché il denaro aumentava il potere e danneggiava la comunità. Platone, insomma, era per una società collettivista.
I due concordavano, però, nel guardare con sospetto il commercio. Platone era addirittura un fanatico dell’autarchia come modello da perseguire. Aristotele, invece, ammetteva il commercio, ma solo se era davvero utile al bene della “polis”, cioè della città nella quale l’uomo, animale sociale, si poteva realizzare pienamente. Quindi era pure lui favorevole alla città autosufficiente che limitava i commerci con altre città in quanto i mercanti stranieri erano spinti solo dal guadagno e non dal bene comune e, di conseguenza, potevano guastare il tessuto sociale e morale della “polis”.
Aristotele (che aborriva l’usura e i monopoli) è, inoltre, importante perché è stato il primo a ragionare sul “giusto prezzo” di una merce; tema che ci portiamo dietro ancora oggi. Il filosofo era partito da una distinzione fra il valore d’uso e il valore di scambio di un bene ricorrendo alle scarpe a mo’ di esempio.
Le scarpe, infatti, hanno un valore diverso se il loro fine è quello di essere calzate oppure se è quello di essere usate come mezzo di scambio o, ancora, di essere pagate con moneta sonante perché allora può entrare in campo la cupidigia. Questo è il suo ragionamento: se la ricchezza posseduta e da tutelare mi serve per far vivere bene la mia famiglia, allora è buona cosa; se invece diventa il mezzo per accumulare ricchezza, allora questo strumento va contro natura perché va oltre quanto è necessario alla sopravvivenza della famiglia. In altre parole ancora, Aristotele definisce naturale lo scambio di autosussistenza e lo distingue dal commercio fine a se se stesso, o arte del fare soldi, che definisce innaturale.
Come si stabilisce, a questo punto, il “giusto prezzo” di una merce che passa dal venditore al compratore? Per spiegarlo, Aristotele ricorre all’esempio del contadino e del calzolaio ognuno dei quali ha bisogno del prodotto dell’altro. I due, perciò, si scambiano cibo contro scarpe. Poiché per Aristotele l’economia rientra nella sfera dell’etica, il giusto prezzo si avrà solo quando sarà stabilito «il giusto pareggio tra l’opera del calzolaio e quella dell’agricoltore».
E su un fatto, i due filosofi, erano d’accordissimo (e la loro filosofia ha permeato anche il pensiero degli antichi romani): il lavoro è roba da schiavi perché sono loro a do-ver provvedere a tutto ciò che è “necessario” alla “polis”. Lo schiavo, con il suo lavoro manuale, infatti, doveva permettere al cittadino ateniese di dedicarsi totalmente alla politica (alla quale partecipavano solo gli uomini adulti, non le donne, i bambini e gli schiavi) e alla riflessione grazie anche all’ozio.